La Cappella Sistina è considerata uno dei gioielli più belli e preziosi del Rinascimento
Italiano.
Il recente restauro ha messo in luce numerosi particolari del capolavoro del
Michelangelo che, nei secoli, innumerevoli strati di sporcizia e oscurità avevano
nascosto alla vista e che ora hanno permesso ad alcuni studiosi di evidenziare il
messaggio “criptico” che Michelangelo stesso aveva voluto inviare alla chiesa cattolica
del tempo, messaggi relativi alla riconciliazione tra ragione e fede, tra Bibbia, Talmud
e Vangeli, validi ancora oggi.
 Questi studi, di cui ci serviamo per commentare i bellissimi
francobolli realizzati negli ultimi anni, non solo dalle Poste
del Vaticano, sono stati elaborati dal Rabbino Benjamin
Blech, professore di Talmud alla Yeshiva University,
docente di fama internazionale e tra i pochi che ebbero
occasione di incontrare nel gennaio del 2005, Giovanni Paolo
II in Vaticano, dove volle ricevere un’ultima benedizione dai rappresentanti dei
“fratelli maggiori” e consolidare i legami
tra queste due fedi. Inoltre accompagnò
nel 2006 papa Benedetto XVI a visitare
Auschwitz durante il viaggio pastorale in
Polonia.
Questi studi, di cui ci serviamo per commentare i bellissimi
francobolli realizzati negli ultimi anni, non solo dalle Poste
del Vaticano, sono stati elaborati dal Rabbino Benjamin
Blech, professore di Talmud alla Yeshiva University,
docente di fama internazionale e tra i pochi che ebbero
occasione di incontrare nel gennaio del 2005, Giovanni Paolo
II in Vaticano, dove volle ricevere un’ultima benedizione dai rappresentanti dei
“fratelli maggiori” e consolidare i legami
tra queste due fedi. Inoltre accompagnò
nel 2006 papa Benedetto XVI a visitare
Auschwitz durante il viaggio pastorale in
Polonia.
Il coautore è il prof. Roy Doliner, di New
York, cattolico, studioso di religioni
comparate, chiamato spesso a tenere
lezioni accademiche e accompagnare
autorità in visita a Roma e nei Musei
Vaticani.
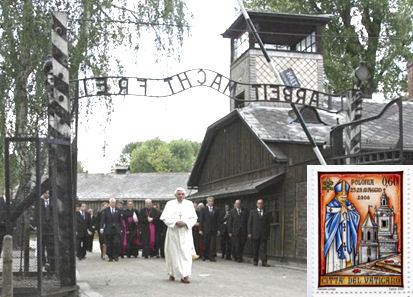 |
La Cappella
 La costruzione della Sistina, voluta dal Papa
Sisto IV, Francesco Della Rovere (1414-1484),
è nata già come “atto ostile” agli ebrei, in
quanto rispecchia esattamente le
caratteristiche del Sacro Tempio di
Gerusalemme, costruito da Salomone nel 930
a.C., descritto dal Profeta Samuele (I Re 6,2).
La costruzione della Sistina, voluta dal Papa
Sisto IV, Francesco Della Rovere (1414-1484),
è nata già come “atto ostile” agli ebrei, in
quanto rispecchia esattamente le
caratteristiche del Sacro Tempio di
Gerusalemme, costruito da Salomone nel 930
a.C., descritto dal Profeta Samuele (I Re 6,2).
Sia nel Talmud, che nei vari testi sacri ebrei è
espressamente fatto divieto di costruire
questo tempio in altro luogo se non sul Monte
del Tempio di Gerusalemme.
 |
La volontà di Giulio II è stata quella di ribadire che Roma era la nuova
Gerusalemme e il nuovo Tempio conteneva la nuova e unica fede che
invalidava la precedente in quanto gli ebrei, condannando Gesù, erano
destinati ad un perenne esilio.
Michelangelo
Michelagnolo Buonarroti nacque il 6 marzo 1474 a Caprese, nei pressi di Arezzo, visse gli anni della fanciullezza in conflitto con la famiglia e a tredici anni andò a Firenze come apprendista della bottega del Ghirlandaio. Firenze, all’epoca di Cosimo e Lorenzo il Magnifico dei Medici, era il vero centro del mondo per tutto ciò che riguardava la cultura, le idee, l’arte. Lorenzo si accorse presto della eccezionale bravura del giovane Michelangelo e lo volle accogliere nel suo palazzo e farlo studiare con i suoi figli (tra cui Giovanni, dapprima cardinale a 13 anni poi papa Leone X ).
 |
 |
Ebbe come maestri i più grandi filosofi del tempo: Pico della Mirandola e Marsilio Ficino, nonché i più sapienti cultori ebrei che, espulsi da tutta Europa, erano ospiti graditi alla corte dei Medici. Questa profonda conoscenza ed accettazione della cultura ebraica influenzerà chiaramente tutta la sua opera.
 |
Il Papato
Nel XV secolo il papato visse uno dei periodi peggiori della propria storia. Anche dalla lettura dello cronaca da parte Vaticana (Storia dei Papi di mons. Castiglioni, Prefetto della Biblioteca Ambrosiana del 1965) emerge un quadro desolante (ricchi casati in conflitto tra loro, cardinali eletti giovanissimi a 13-17 anni, figli e nipoti di papi, diventati a loro volta papi, voti acquistati con ricche prebende, simonia…, libertinaggio, omosessualità. Il paganesimo in quel secolo era salito al livello più alto nella società e nella chiesa; il disprezzo della vita umana, l’adulterio; di figli bastardi e illegittimi sono piene le corti principesche e il papato assumeva l’aspetto di un temuto e potente principato ecclesiastico… (papa Alessandro VI Borgia - nipote del papa Callisto III - eletto nel 1492, “come sacerdote fu l’antitesi dell’ideale cristiano”…, Pio III, nipote di Pio II morì nel 1503, dopo 26 giorni di pontificato lasciando “il posto” al nipote di Sisto IV, Giulio II della Rovere; il papa Sisto IV aveva nominato ben sei nipoti cardinale).
 |
 |
Evidentemente in questo contesto non poteva non emergere un Savonarola,
bruciato poi al rogo o un Lutero e il diffondersi del protestantesimo, i Lanzichenecchi e il
“Sacco di Roma” …
Per contro il papato fu il più grande mecenate del periodo. Per la ricostruzione dei palazzi
vaticani furono chiamati i più grandi architetti, pittori, scultori, poeti, scrittori… dell’epoca
favorendo il superamento del Medioevo e dando vita al periodo chiamato poi “Rinascimento”.
Giulio II il Papa della Sistina
 Nel 1503 Giuliano Della Rovere, divenuto papa Giulio II, diede ordine al Bramante di demolire
la vecchia basilica e ricostruirne una enorme degna del nuovo papa e dell’impero cristiano e a
Michelangelo di scolpire le statue per il sepolcro dello zio Sisto IV.
Nel 1503 Giuliano Della Rovere, divenuto papa Giulio II, diede ordine al Bramante di demolire
la vecchia basilica e ricostruirne una enorme degna del nuovo papa e dell’impero cristiano e a
Michelangelo di scolpire le statue per il sepolcro dello zio Sisto IV.
Nel 1508 il papa impose
allo scultore di sospendere la realizzazione delle statue e di dar
corso alla pittura del soffitto della cappella (che il Buonarroti
accettò a malincuore non ritenendosi pittore) lavoro che lo occupò
per oltre quattro anni. Sul soffitto doveva essere rappresentato,
secondo il progetto del papa (e dei suoi consulenti) Gesù e i dodici
apostoli che avrebbero dovuto benedire il papa al suo ingresso nella
cappella, per trasmettere il concetto che Giulio II fosse stato scelto
da Dio per guidare il mondo intero…, mente il resto doveva essere
coperto da una fantasia di disegni geometrici (come il pavimento) di
colori giallo oro e blu (i colori del casato dei Della Rovere).
Michelangelo accettò a condizione che potesse scegliere lui i
collaboratori, che il tema fosse la Bibbia, che potesse lavorare (con un ponteggio da lui ideato
e che lo nascondeva da sguardi indiscreti) indisturbato anche per 24 ore di seguito.
 (La Guardia Svizzera Pontificia, voluta da Giulio II nel 1505; la tradizione vuole che la loro divisa l’abbia
disegnata Michelangelo)
(La Guardia Svizzera Pontificia, voluta da Giulio II nel 1505; la tradizione vuole che la loro divisa l’abbia
disegnata Michelangelo)
Sappiamo che spesso litigò con il papa che lo colpì anche con
il suo bastone pastorale! Erano due caratteri forti e testardi
ma alla fine il Michelangelo riuscì a realizzare il suo
capolavoro inserendo nei dipinti il suo disgusto per il potere e
l’ipocrisia del papato, il messaggio di amore universale
proprio dell’originario insegnamento biblico, l’importanza e la
dignità del corpo umano.
L’affresco è il più grande mai realizzato: 1.100 metri
quadrati a 20 metri di altezza dal suolo, oltre 300
personaggi, cinque anni di lavoro estenuante. Michelangelo lo
finì nel 1512, fu inaugurato il 31 ottobre e pochi mesi dopo
(febbraio 1513) il papa morì. Michelangelo, sperava di aver chiuso il suo impegno con i dipinti,
ma non sapeva che 23 anni dopo sarebbe ritornato alla Sistina per realizzare il Giudizio
Universale.
Nella Cappella col naso all’insù
Numerose sono le tesi sull’interpretazione degli affreschi, la versione “ufficiale” è che i pannelli intendono illustrare le origini dell’uomo, la sua caduta, la riconciliazione con Dio e la promessa di futura redenzione… però questa interpretazione “devota” mal si concilia con il fatto che delle trecento figure nessuna è “cristiana”, numerosi sono gli “sberleffi” nascosti nei personaggi dipinti, molte scene non rispecchiano la tradizione iconografica cattolica.
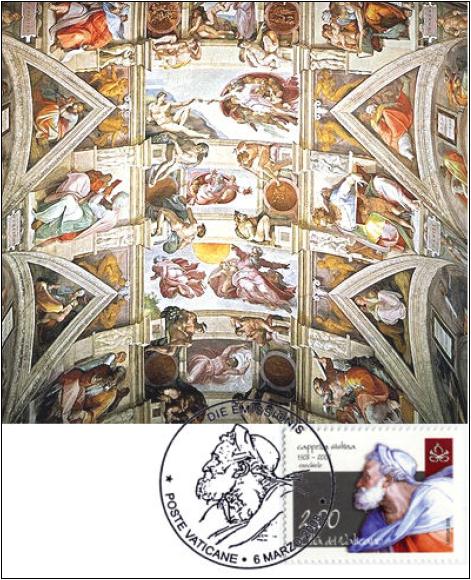 |
Zaccaria
Seguendo l’itinerario originale (ora l’ingresso è stato mutato) sopra la sedia del pontefice c’è il profeta Zaccaria, (con il volto di Giulio II) uno dei meno conosciuti di Israele, al posto previsto di Gesù! Perché Zaccaria era il profeta che ammoniva i corrotti sacerdoti del Tempio e preannunciava che sarebbe stato dato alle fiamme. Inoltre uno dei due putti abbracciati alle spalle del profeta fa un gestaccio con la mano (infila il pollice tra l’indice e il medio facendo il gesto dei “fichi”, l’equivalente dell’epoca al nostro dito medio retto…).
 |
Vele e lunette
I grandi pannelli della striscia centrale sono circondati da giganteschi nudi di giovani, con coppie di piccoli putti anche loro nudi che sembrano scolpiti nella pietra e che alcuni vollero far ricoprire con vesti!
 |
Nelle vele e nelle lunette sono stati dipinti “gli antenati” di
Gesù. Vi sono dipinte varie scenette di famiglie ebree
aggraziate, premurose e belle, in contrasto con la caricatura
corrente di ebrei tristi e stanchi, costretti ad un doloroso
esilio. Nei costumi pregiati sono evidenziate le varie etnie
ebraiche, a dimostrazione che l’intenzione non era di
rappresentare un popolo punito e sofferente ma civile e degno
di rispetto e
cittadinanza (all’epoca iniziavano i ghetti).
Durante la ripulitura degli affreschi è
emerso chiaramente un anello giallo, cucito
sulla tunica dell’avambraccio sinistro di
Aminabad, ritto e dignitoso, noto al Talmud
come buon padre e capo di una tribù ai tempi
di Mosè. Questo “marchio d’infamia” sulla
tunica era imposto dalla chiesa agli ebrei,
come dire “è così che trattate gli antenati
di Gesù?”.
 |
Una compagnia anomala
I personaggi “più importanti” come dimensioni che in modo imponente occupano gli spazi
dedicati agli apostoli tutt’intorno all’affresco sono sette profeti ebrei e cinque sacerdotesse
pagane: un gruppo unico nell’arte sacra cristiana! Tutti i personaggi (escluso Giona) hanno in
mano un libro o un rotolo a dimostrazione che erano degli amanti della cultura a differenza di
Giulio II che volle farsi fare una statua con in mano la spada!
Le sibille rappresentano gli imperi che avevano tentato di cancellare gli ebrei: egizio,
babilonese, persiano, greco e romano. Però le tre più famose il cui ruolo profetico di
preannuncio della venuta del Cristo (Triburtina, Ellespontica e Samia) era riconosciuto dalla
chiesa, non sono state rappresentate.
 |
Le sibille: Delfina,
Eritrea e Libica, hanno
tutte in comune, oltre
che specifici significati
per la loro presenza,
caratteristiche sessuali
molto ambigue (corpi
mascolini di adolescenti);
Persica invece in un corpo possente ha un viso  vecchio e
nell’affresco della sibilla Cumana, che secondo le credenze
dell’epoca avrebbe previsto anche l’ascesa al trono di Giulio
II, Michelangelo la dipinge con un volto decrepito, vestita
dei colori blu e oro dei Della Rovere mentre i due
“angioletti” sono rappresentati con lo stesso gesto scurrile
di “fare i fichi”, come con Zaccaria.
vecchio e
nell’affresco della sibilla Cumana, che secondo le credenze
dell’epoca avrebbe previsto anche l’ascesa al trono di Giulio
II, Michelangelo la dipinge con un volto decrepito, vestita
dei colori blu e oro dei Della Rovere mentre i due
“angioletti” sono rappresentati con lo stesso gesto scurrile
di “fare i fichi”, come con Zaccaria.
Anche per i profeti la scelta è caduta su alcuni che avevano
un chiaro significato “antipotere”
mentre sono stati
omessi altri che erano più citati
dalla chiesa. Oltre al già citato
Zaccaria, anche Gioele e Isaia
che avvertì gli ebrei delle terribili avversità e sofferenze che
avrebbero dovuto sopportare, esortandoli a mantenere la fede.
 |
Ezechiele che garantì agli ebrei sofferenti che
avrebbero alla fine riconquistato Gerusalemme. Daniele dipinto come un giovane di grande bellezza e
intelligenza, è il simbolo di una futura redenzione per
ebrei e cristiani.
 |
 L’affresco di Geremia ha più aspetti simbolici: il suo volto angosciato ha lo sguardo fisso sul
posto che di solito era occupato dal baldacchino papale. Geremia era il profeta inviato da Dio
per avvisare il clero corrotto del secondo tempio che il loro oro e bronzo sarebbero stati
saccheggiati e l’edificio distrutto se non avessero contrastato il degrado morale imperante.
L’affresco di Geremia ha più aspetti simbolici: il suo volto angosciato ha lo sguardo fisso sul
posto che di solito era occupato dal baldacchino papale. Geremia era il profeta inviato da Dio
per avvisare il clero corrotto del secondo tempio che il loro oro e bronzo sarebbero stati
saccheggiati e l’edificio distrutto se non avessero contrastato il degrado morale imperante.
Nella tradizione ebraica Geremia è l’autore delle
“Lamentazioni” che rievoca la devastazione di Gerusalemme
ad opera dei babilonesi. Anche i due personaggi minori non
sono i soliti putti con i colori rosso e giallo (i colori di Roma
ancora oggi) dai volti tristi che sembrano voler fuggire dalla
città. Anche il rotolo ha delle lettere ben leggibili che hanno
un significato criptico.
 L’ultimo profeta dipinto sopra l’altare è Giona, un profeta
minore. Giona è un po’ l’immagine del Michelangelo, il profeta
involontario che ha
dovuto accettare un
incarico di
malavoglia. Molte sono le curiose affinità con il
pittore. Sono brani di Giona che vengono letti da tutti
gli ebrei del mondo nel Giorno dell’Espiazione, il giorno
in cui Dio “scrive” il suo verdetto su ciascuno di noi.
L’ultimo profeta dipinto sopra l’altare è Giona, un profeta
minore. Giona è un po’ l’immagine del Michelangelo, il profeta
involontario che ha
dovuto accettare un
incarico di
malavoglia. Molte sono le curiose affinità con il
pittore. Sono brani di Giona che vengono letti da tutti
gli ebrei del mondo nel Giorno dell’Espiazione, il giorno
in cui Dio “scrive” il suo verdetto su ciascuno di noi.
Molti sono i messaggi in questo dipinto che è il più
grande di tutti e sembra emergere dal soffitto in tre
dimensioni: un angioletto segna con la mano allargata il
numero cinque, che significa la Torah e che contiene
molti altri significati; il pesce non è la “balena” della
tradizione cristiana ma il “Leviatano” il pesce sacro di
cui si ciberanno gli ebrei alla venuta del Messia, ecc.
Nel cuore degli affreschi
 Le storie centrali sono le più celebri, quelle che vengono
riprodotte in continuazione e sono state oggetto di una
bellissima serie di quattro dittici nel 2000.
Le storie centrali sono le più celebri, quelle che vengono
riprodotte in continuazione e sono state oggetto di una
bellissima serie di quattro dittici nel 2000.
La creazione del mondo
Nel primo pannello Dio con il volto accigliato e in una
posizione contorta (come probabilmente era
Michelangelo quanto dipingeva sul soffitto), separa il
cielo con le mani. Il corpo del Creatore richiama la
statua di Laocoonte.
La creazione degli Astri e delle Piante
Nel secondo pannello, la prima parte separa la luce (il sole) dalle tenebre (la luna), nella
seconda parte c’è la creazione delle piante ed è evidente lo “sfogo” del pittore con un insulto
ben chiaro al papa. Per la prima e unica volta nella storia della pittura, Dio è stato
rappresentato voltato nella
direzione opposta
all’osservatore, mostrando
“la parte posteriore”
orientata proprio verso
l’area cerimoniale del papa.
 |
La creazione dell’uomo
È certamente il dipinto più famoso
della “Sistina”. Questo affresco ha
suscitato nei secoli numerosi
interrogativi: chi è la giovane donna
sotto il braccio sinistro di Dio?, e il
bambino sotto la sua mano?, perché
Dio ha bisogno di diversi angioletti
intorno?, e cos’è lo strano mantello a forma di aquilone… Molte sono le interpretazioni… tra le
altre un noto chirurgo ebreo sostiene che è riprodotto il concetto della Cabala che Dio creò
Adamo con Chochmà, la parte destra del cervello (dove alloggia la sapienza) e quel strano
“tendaggio” rappresenta proprio il cervello di cui certamente Michelangelo era a conoscenza
avendo provveduto a diverse vivisezioni di cadaveri.
  |
La creazione di Eva
Anche questo pannello rispecchia la conoscenza
ebraica: Eva non era uscita da una costola di Adamo
ma dal fianco perché gli stesse vicina nella vita come
compagna di pari dignità.
 |
Il Peccato Originale
Anche questo è un dittico con
molti particolari “sovversivi” e
diversi dall’interpretazione
cristiana: già la posizione di
Adamo ed Eva (vicino ai
genitali) dà una visione
“vietata” dal comune senso del
pudore!
Secondo il Talmud, il frutto
proibito non è stato preso da
Eva e dato ad Adamo ma tutti
e due lo prendono dal
“maligno”. Il frutto non è una mela ma, come chiaramente dipinto, un fico. Il Midrash descrive
il “serpente” munito di braccia e di gambe, come rappresentato da Michelangelo e l’angelo
virtuoso che li scaccia da Paradiso è il “gemello identico ma contrapposto” al maligno. Sia i
gesti che le posizioni sono speculari.
La Chiesa cattolica, fino alla fine del XIX Secolo, aveva proibito la diffusione dell’immagine di
questo pannello!
 |
Il diluvio universale
Anche in questo caso per capire il dipinto bisogna rivolgerci al Talmud. L’arca di Noè non è un
barcone come l’iconografia cristiana
l’ha sempre descritta. Nella
letteratura ebraica l’arca era un
contenitore (una sinagoga?) che
rimaneva in superficie perché
sostenuta dall’Alito di Dio.
 |
Nella grande scena l’unico animale che vi appare è la testa di un asino (alla sinistra) che si confonde con i colori vivaci rosso e giallo (i colori di Roma).
Dal lato opposto, dietro la tenda provvisoria che dovrà sparire sommersa dall’acqua vi sono due figure che hanno vesti rosso e giallo!, (come lo sfondo dove appare l’asino…) destinate ad annegare per i loro peccati in quanto si salveranno solo gli esseri viventi che sono a bordo dell’arca.
 |
Il messaggio di Michelangelo era chiaro: la chiesa dell’epoca che tendeva a disconoscere il valore dell’Antico Testamento riconoscendo validità solo al Nuovo era una Chiesa che dimenticava le proprie radici della Torah e le scritture ebraiche, avrebbe finito fatalmente per smarrirsi.
 |
 |
Il Giudizio Universale
 Clemente VII, Giulio de Medici (1478-1534) “fratello” di
studi di Michelangelo, diventato papa nel 1523 (due anni
dopo la morte del cugino papa Leone X, Giovanni de
Medici), lo volle richiamare a Roma per affidargli, all’età
di 59 anni, il rifacimento della parete d’altare della
Cappella Sistina. La parete era già ricoperta da preziosi
capolavori: l’ascensione al cielo della Vergine (a cui era
dedicata la cappella) con il papa Giulio II inginocchiato, del Perugino e due pannelli dei cicli di
Gesù e di Mosè del Botticelli. Il Papa, conoscendo bene Michelangelo, gli impose di dipingere
un Giudizio Universale ma ben presto morì.
Clemente VII, Giulio de Medici (1478-1534) “fratello” di
studi di Michelangelo, diventato papa nel 1523 (due anni
dopo la morte del cugino papa Leone X, Giovanni de
Medici), lo volle richiamare a Roma per affidargli, all’età
di 59 anni, il rifacimento della parete d’altare della
Cappella Sistina. La parete era già ricoperta da preziosi
capolavori: l’ascensione al cielo della Vergine (a cui era
dedicata la cappella) con il papa Giulio II inginocchiato, del Perugino e due pannelli dei cicli di
Gesù e di Mosè del Botticelli. Il Papa, conoscendo bene Michelangelo, gli impose di dipingere
un Giudizio Universale ma ben presto morì.
Gli successe Paolo III Alessandro Farnese, (fatto cardinale a 17 anni perché fratello di Giulia,
l’amante del papa Borgia) due figli riconosciuti, tre nipoti fatti cardinali, di cui uno diventato
poi papa Paolo IV nel 1555, che lasciò proseguire nell’affresco del Giudizio Universale, anzi
nominò Michelangelo “architetto di San Pietro”.
 Paolo III è il primo da destra nel francobollo del 1935 del Vaticano. Vi figurano anche Giulio II, Gregorio IX e Paolo III è il primo da destra nel francobollo del 1935 del Vaticano. Vi figurano anche Giulio II, Gregorio IX e Leone X |
 Paolo III e due nipoti Paolo III e due nipoti
|
 Michelangelo sottopone a Paolo IV il suo progetto per la costruzione di San Pietro Michelangelo sottopone a Paolo IV il suo progetto per la costruzione di San Pietro |
 Per prima cosa Michelangelo, non solo dovette distruggere gli affreschi, ma fece
chiudere le finestre e modificare la parete d’altare per darle l’immagine delle
Tavole della Legge. Per più di sette anni dipinse l’affresco dall’alto in basso, quasi
sempre da solo. Michelangelo rimaneva lo stesso ribelle e quindi nel suo “Giudizio”,
il più grande affresco mai realizzato da un solo pittore, sono presenti numerose
“provocazioni”.
Per prima cosa Michelangelo, non solo dovette distruggere gli affreschi, ma fece
chiudere le finestre e modificare la parete d’altare per darle l’immagine delle
Tavole della Legge. Per più di sette anni dipinse l’affresco dall’alto in basso, quasi
sempre da solo. Michelangelo rimaneva lo stesso ribelle e quindi nel suo “Giudizio”,
il più grande affresco mai realizzato da un solo pittore, sono presenti numerose
“provocazioni”.
 |
In alto, sotto i due archi, gli angeli, che non hanno ali né aureole, sono dei giovani con corpi
atletici e genitali umani che portano i simboli della Passione. A sinistra la croce, la corona,
simboli femminili e a destra la colonna inclinata, simbolo maschile.
 |
Sotto gli angeli ci sono le anime dei
giusti in cerchio sopra il capo di Gesù.
Non si tratta di santi celebri, o papi o
nobili importanti ma anime “giuste”, tra
queste, proprio sopra il capo di Gesù un
angelo vestito di rosso indica due uomini
che sono chiaramente ebrei! Uno con il
cappello a due punte e l’altro con il
copricapo giallo, ambedue segni
distintivi d’infamia ordinati dalla chiesa.
Accanto un giovane nudo che ha tutte le
sembianze del maestro Pico della
Mirandola. Erano certamente immagini
blasfeme… sino a poco fa il paradiso era
solo per i “cristiani”, gli altri al massimo
andavano nel limbo.
Dal lato opposto, tra i giusti appaiono
moltissime donne (anche qui con corpi
muscolosi e con nudità palesi). Nel
periodo in cui i teologi discutevano se le
donne avessero o meno un’anima anche questo messaggio era provocatorio.
A differenza di tutti i suoi contemporanei i “giusti” non avevano atteggiamenti pii, seri ma
molto più espansivi: si abbracciano e si baciano contenti, anche tra maschi...
Al centro domina la figura del Cristo, in radicale rottura
con le immagini tradizionali: un giovane muscoloso,
sensuale e severo; immagine più vicina all’Apollo greco. La
Sua Mamma sembra distrarre lo sguardo dalla punizione
illustrata dall’altra parte dell’affresco.
 |
Una curiosità emersa durante il restauro: a differenza
delle altre immagini il volto della Madonna è stato dipinto
con la tecnica del “pointillisme” (puntini colorati, tecnica
inventata poi a Parigi a fine ‘800!).
Alcuni santi sono stati dipinti con i simboli del loro
martirio: san Bartolomeo protettore degli stuccatori è
riprodotto con la sua pelle in mano (era stato scuoiato)
ma sulla pelle c’è l’autoritratto di Michelangelo. San
Lorenzo, il santo bruciato sulla graticola (che però è
ritratto con una scala – di Giacobbe – simbolo, secondo la
Cabala, del legame tra cielo e terra, era il tesoriere della
prima comunità cristiana di Roma che aveva detto ai pagani che la ricchezza della chiesa non
era l’oro ma la fede della gente comune… e per questo subì il martirio.
 |
 |
Non è l’ubbidienza cieca alla chiesa o le offerte importanti al papato (costruzione chiese,
proselitismo, guerre per conto del Papa ecc.) che procurano la salvezza. Michelangelo nel
dipinto l’ha voluto dimostrare: a differenza di molti altri pittori che elogiavano i donatori lui
ha voluto mettere in paradiso i giusti “comuni”, anche quelli che, aggrappati alla fede semplice
(la preghiera del rosario) sono riusciti a salvarsi.
Al centro i sette angeli dell'apocalisse risvegliano i morti al suono delle lunghe trombe; a
sinistra i risorti in ascesa verso il cielo recuperano i corpi (resurrezione della carne), a destra
angeli e demoni fanno a gara per precipitare i dannati nell'inferno. Due angeli hanno in mano il
libro delle vite.
Nella sezione in basso riservata ai dannati, ci sono numerosi “messaggi”. All’epoca la simonia
era pratica comune nella chiesa e Michelangelo l’ha voluta bollare con l’immagine di un dannato
a testa in giù, con due chiavi in mano e la borsa dell’oro appesa di colore giallo e rosso (tutti
simboli evidenti del papato), violentemente percossa da un angelo.
Per ultimo ha dipinto, proprio
in basso dietro l’altare, il “re
Minosse” all’inferno, con le
orecchie d’asino e il serpente
che gli morde i testicoli… ma il
volto era esattamente quello di
Biagio da Cesena, il maestro di
cerimonie e che si occupava del
controllo per conto del papa,
che già prima che finisse
l’affresco, quest’ultimo aveva
pubblicamente dichiarato che Michelangelo aveva riempito la cappella papale di “un orgia di
oscenità pagane e eresie…”
 |
Già fin dalla inaugurazione nel 1541, la città si divise in due: una parte la riconobbe come capolavoro e l’altra, pagana e oscena.
Per secoli il soffitto è stato ricoperto, più volte lo si è voluto sostituire, il papa Paolo IV ne
aveva decretato la distruzione ma morì fortunatamente nel 1559 prima di poter dare seguito a
quanto deciso. Nel 1564 (dopo la morte di Michelangelo) fu ordinato a Daniele da Volterra di
censurare l’affresco ma, per rispetto al grande maestro, vi apportò solo modifiche marginali.
 Il Papa Giovanni Paolo II, in occasione del
restauro della Cappella, che è durato 20 anni,
durante la Santa Messa celebrata nella
cappella, ha annunciato la “pubblica
riabilitazione” di Michelangelo: “…sembra che
Michelangelo, a suo modo, si sia lasciato guidare
dalle suggestive parole del Libro della Genesi
che, a riguardo della creazione dell’uomo,
maschio e femmina, rileva “Erano nudi ma non
ne provavano vergogna”. La Cappella Sistina è
proprio, se così si può dire, il santuario della
teologia del corpo umano, che rende
testimonianza alla bellezza dell’uomo creato da
Dio come maschio e femmina…Davanti al
Giudizio Universale rimaniamo abbagliati dallo
splendore e dallo spavento…” (8 aprile 1994)
Il Papa Giovanni Paolo II, in occasione del
restauro della Cappella, che è durato 20 anni,
durante la Santa Messa celebrata nella
cappella, ha annunciato la “pubblica
riabilitazione” di Michelangelo: “…sembra che
Michelangelo, a suo modo, si sia lasciato guidare
dalle suggestive parole del Libro della Genesi
che, a riguardo della creazione dell’uomo,
maschio e femmina, rileva “Erano nudi ma non
ne provavano vergogna”. La Cappella Sistina è
proprio, se così si può dire, il santuario della
teologia del corpo umano, che rende
testimonianza alla bellezza dell’uomo creato da
Dio come maschio e femmina…Davanti al
Giudizio Universale rimaniamo abbagliati dallo
splendore e dallo spavento…” (8 aprile 1994)
 |
 |