PERCORSI:
Fatti, personaggi, documenti ed oggetti testimoni di vita e di storia > questa pagina
Dal Fascismo alla Liberazione > questa pagina
Uffici di posta nella vecchia e nuova provincia di Arezzo > L'Ufficio di Posta di Arezzo > questa pagina
PADRE RAIMONDO CAPRARA
 Per essere canonizzati occorre il riconoscimento di almeno un miracolo, Padre Caprara ne ha fatti tanti di miracoli, ma tutti laici e per questo gli è stata dedicata una via in Arezzo, proprio dietro la sua Parrocchia di San Domenico, che ha tramutato il suo nome da Via Dei Bastioni in Via Padre Raimondo Caprara.
Per essere canonizzati occorre il riconoscimento di almeno un miracolo, Padre Caprara ne ha fatti tanti di miracoli, ma tutti laici e per questo gli è stata dedicata una via in Arezzo, proprio dietro la sua Parrocchia di San Domenico, che ha tramutato il suo nome da Via Dei Bastioni in Via Padre Raimondo Caprara.
La maggior opera custodita nella sua basilica/Parrocchia è il Crocifisso del Cimabue. Meno conosciuta è invece la vicenda di Papa Gregorio X che, rientrando a Roma da Lione dove aveva convocato e presieduto un Concilio Ecumenico alcuni giorni prima del Natale 1275, si fermò ad Arezzo. Papa Gregorio soffriva di improvvise febbri debilitanti e, a causa di uno di questi episodi, fu ricevuto e ospitato nel nuovo palazzo vescovile di Arezzo, costruito dal vescovo Guglielmo degli Ubertini. Il 10 gennaio 1276 Gregorio morì nell'episcopio. Quindi, in Arezzo, proprio nella Chiesa di San Domenico, fu celebrato il primo Conclave secondo le regole della Ubi Periculum nel gennaio 1276.
Raimondo Caprara naque a Terranova di Pollino, in provincia di Potenza il 28 maggio 1910, morì in Arezzo il 19 agosto 1980. Fu ordinato parroco di San Domenico nel 1938, a 28 anni, poco dopo si trovò ad affrontare i tristi eventi della guerra:
"Il legame che si era creato con la popolazione fu messo alla prova - ed allo stesso tempo esaltato - dalle tragiche vicende della guerra. La città bombardata e distrutta, le minacce dei nazifascisti, nel periodo compreso tra l’ottobre 1943 ed il luglio 1944, non impedirono a padre Caprara di svolgere la propria missione di sacerdote mettendo, più volte, a rischio la propria vita.
Il Convento di S. Domenico fu un luogo dove furono assistite le tante persone, di diversa nazionalità e fede religiosa, che si trovavano in difficoltà. Padre Caprara aiutò la popolazione aretina e la lotta di Resistenza, ospitando e nascondendo più volte i partigiani, tra loro Antonio Curina, ricercati dai nazi-fascisti. Sotto la sua guida, in quel periodo di guerra, la zona e quanto in essa avveniva fu chiamata la “Repubblica di S. Domenico”. Su questa, padre Caprara, a metà degli anni ’70, scrisse una monografia", questo è quanto di lui ha scritto il compianto amico Agostino Coradeschi (1). Leggi >>>
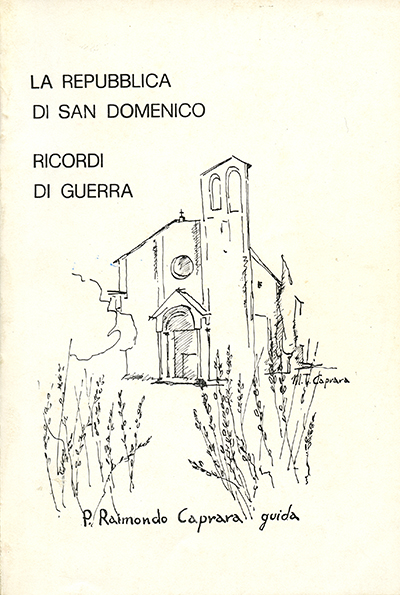 |
LA REPUBBLICA DI SAN DOMENICO, RICORDI DI GUERRA di P. Raimondo Caprara guida O.P. (2), è una autentica testimonianza, vissuta in prima persona, di quanto è accaduto in Arezzo durante il periodo della Repubblica Sociale Italiana, subito dopo l'8 settembre 1943. Nelle pagine autografe c'è il raccondo del dramma da lui vissuto e condiviso, non solo con i suoi parrocchiani, ma con l'intera città e non solo.
Nelle pagine del libro abbiamo trovato una importante testimonianza che, di seguito, integralmente riportiamo. Si tratta del capitolo relativo al funzionamento del servizio postale nei tragici mesi di Repubblica Sociale Italiane, quando la vita cittadina si era fermata, la maggior parte degli aretini erano sfollati nelle campagne e nelle colline circostanti; di conseguenza, anche tutti i servizi risentivano dei questa situazione: in città erano rimasti soltanto i militari addetti al Distretto, alla Scuola (vuota) degli allievi ufficiali di complemento, gli ospedali militari erano 3: “Maria Federici” della C.R.I., “Vittorio Emanuele”, con sede nel Convitto Nazionale ed il “S. Caterina” in Via Garibaldi.
Gli Uffici cittadini erano stati trasferiti in piazza S. Domenico (Genio civile, alle Scuole Vasari e Poste), a S. Fabiano (Prefettura, Comune), all’Olmo (Banca d’Italia) e in Via Casentinese (scuole “Vasari”).
POSTE PROVINCIALI
Problema essenziale per gli abitanti di S. Domenico era tener lontano le forze armate specialmente tedesche. Perciò non fu senza preoccupazione che un giorno del dicembre del 1943, vidi stazionare in piazza alcuni alti ufficiali tedeschi. Prima che bussassero al Convento, intuendo le loro intenzioni, mi attaccai al telefono e proposi all'Economo provinciale delle Poste, Sig. Enrico Matteini, di trasferire la Direzione e i servizi delle Poste nel Convento e nel Collegio di S. Domenico. Gli dissi che non c'era possibilità di discutere le modalità né d'interpellare il Direttore Comm. Tussi e l'ispettore Dott. Gori, assenti. Dovevamo mettere il comando tedesco di fronte al fatto compiuto. Ci mettemmo d'accordo e agli ufficiali tedeschi che attendevano in portineria potei dire che i locali erano stati già requisiti per ospitare le Poste provinciali, gli uffici postali della ferrovia, nonché la Succursale n. 1. Il trasloco cominciò il giorno stesso. Così il Convento si trasformava in Sede delle poste provinciali. Fu forse la sua fortuna, ma lo fu certamente per le Poste. Non solo perché gli impiegati poterono svolgere il loro lavoro, almeno per alcune ore al giorno, con relativa tranquillità, ma anche perché nulla andò perduto del patrimonio delle Poste, dai mobili alle borse di cuoio dei portalettere. Nelle soffitte trovarono posto le macchine da scrivere, calcolatrici e tutta la roba che fu possibile trasportarvi; sotto le panche della Cappella furono nascoste le borse di un ottimo cuoio che faceva gola a parecchi. Furono salvate finanche le poltroncine e il pianoforte del dopolavoro ferroviario che, subito dopo la liberazione, per non aver voluto dar retta a me, andarono a finire a Rimini per rallegrare le truppe alleate, da cui furono requisite appena riportati nella vecchia sede.
Un capitolo a parte meriterebbe la cassaforte. Sapevo che conteneva, tra valori bollati e danaro liquido, più di tre milioni.
Proposi di prelevarli e depositarli presso il Vescovo, che ormai era diventato il tesoriere di Arezzo. Mi fu risposto, da uno dei tre cassieri, che a lui non importava nulla della fine che avrebbero fatto quei valori: aveva verbalizzato il contenuto, aveva chiusa la cassa davanti ai testimoni, ciascun cassiere aveva avuto una delle tre chiavi, il suo compito era terminato. Rimasto solo camuffai così bene la cassaforte che passò inosservata finanche ai tedeschi nelle loro non rare visite al Convento in cerca di corpi di reato.
A liberazione avvenuta feci noto al maggiore italo-americano Tria e al tenente ispano-americano Fernandez, i nomi dei cassieri. Furono convocati per aprire la cassaforte. Probabilmente il primo a farsi lo stipendio fu quello dei tre cassieri che si era rifiutato di provvedere in modo adeguato alla salvaguardia del patrimonio dello Stato, cioè di tutti.
Naturalmente la mia nuova posizione di quasi direttore provinciale delle Poste mi diede la possibilità di fare un po' di bene.
Insieme col sig. Ceccherelli fabbricammo qualche tessera postale tanto necessaria ad alcuni ufficiali e soldati sbandati, non partigiani ma neanche aderenti alla R.S.I. Credo che questo reato sia ormai passato in prescrizione. Comunque se qualcuno volesse denunziarci, ricordi che si agiva contro un potere illegittimo!
Ormai posso dirlo: molti si attribuirono il merito della conservazione dei beni comuni o per crearsi una verginità di fronte ai nuovi padroni o per accampare benemerenze alle quali non avevano alcun diritto. Ma ripeto, oltre il signor Ceccherelli e il signor Matteini (che per l'eccessiva modestia non accettò la carica di Direttore provinciale) nessun funzionario si preoccupò minimamente della sorte dei beni dello Stato. Il sig. Enrico Matteini "prese alloggio in una stanza adibita ad Ufficio e vi rimase notte e giorno. Solo verso la fine di giugno raggiunse la famiglia sfollata a Subbiano, ma finché gli eventi lo permisero, non tralasciò mai di fare una visita quotidiana agli uffici postali, percorrendo a piedi il tragitto Arezzo Subbiano.
Né va dimenticato il Cav. Santi Galimberti, anche lui funzionario delle Poste provinciali, che mi fu largo di aiuto e soprattutto di consigli, dei quali dato il mio ardore giovanile e la mia inesperienza delle cose e degli intrighi del mondo, avevo molto bisogno [(pagg. 37-39 - dicembre 1943) - (2)].
...
Al Signor Severino Basagni erano rimasti due autofurgoni con i quali, sbrigava il servizio postale. Quando cessò in città ogni attività, compreso il servizio postale, venne a scongiurarmi perché gli salvassi quell’unico tesoro. Gli dissi che poteva nascondere o camuffare come meglio credesse gli automezzi. L’autista, di cui non ricordo il nome, ma che qualche volta incontro ancora per Arezzo, smontò e nascose i pezzi asportabili finanche nella soffitta della Chiesa, mentre gli “chassy” rimasero nella legnaia che avevo affittato al signor Basagni per Lire 40 mensili. Ritornato dallo sfollamento, il signor Basagni ritirò gli automezzi, ma non avemmo il tempo di fare i conti dell’affitto dal gennaio all’ottobre 1944.
NOTA
1) - http://www.societastoricaretina.org/biografie/CACapraraRaimondo190404.pdf (visitato il 7/2/2018)
2) - P.Raimondo Caprara guida, La Repubblica di San Domenico Ricordi di guerra, Arezzo, Tipografia Palmini & C., 1985
