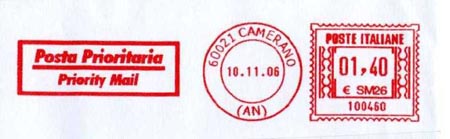|
da Canneto a Lucca:
cortesemente vorrei avere delucidazioni in merito alla lettera in
allegato ed in particolare:
1) al bollo in rosso applicato al
verso <<...1837 / 12 GEN.>>
2) al manoscritto: <<g. 19>>
3) al segno in rosso: <<7>>;
forse superava il peso?
All'interno è
riportato: "La prego dare al mio caro D. Felice l'acchiusa lettera."
Ringrazio per l'attenzione
Luigi De Felice

vai ai
maggiori dettagli >>>
|
Tariffario del Regno d'Italia napoleonico
qualche studioso che ha o ha visto il tariffario applicato nel Regno d'Italia napoleonico, o nelle Repubbliche precedenti, per le lettere provenienti dall'estero, dalla Francia in particolare.
Fabrizio Salami [salami.fabrizio@gmail.com]
|
CHE ROSSA E' ?
Ho trovato questa busta con una strana impronta rossa di affrancatura del giugno 2003 e come si può vedere dalla codificazione postale del CAP di consegna è stata regolarmente passata per posta. Dalla risoluzione grafica ingrandita dell'impronta si vede che è sicuramente effettuata con una stampante da computer. Da escludere perciò che sia una "rossa" delle solite, fatta con le consuete macchine affrancatrici con "punzone di stato", data in concessione dalle poste.
Mi chiedevo se non fosse un 'impronta di una delle tentate affrancature on-line tipo "postebollo" iniziate nel "lontano" 2001 ancora con le vecchie lirette e forse continuate anche con l'Euro. Nella parte inferiore dello pseudo-francobollo c'è un numero, ho controllato tutte le impronte di affrancatura moderne che ho e non ho trovato nessuna impronta che riportasse un numero all'interno dell'impronta di valore. Chiedo aiuto ai soci dell'AICAM che sanno tutto sulle "rosse".
Grazie anticipate Marino Bignami


RISPOSTA AL QUESITO DI MARINO BIGNAMI
Invece si tratta proprio di una semplice “rossa” muta (cioè senza indicazione dell’utente). Impronte con questo punzone (tipo P 34 della classificazione AICAM) sono abbastanza comuni: nel mio archivio ne sono registrate più di 1600, con o senza l’indicazione dell’utente, ed un grosso accumulo deve ancora essere visionato e registrato.
Per l’impronta oggetto del quesito conosco, come date estreme, 19.02.03 e 20.03.07 e tutte le impronte visionate, sempre mute, sono impresse su buste intestate dello stesso mittente (IN-PUT di Roma) che risulta, pertanto, essere l’utente dell’affrancatrice.
L’impronta è di una affrancatrice Neopost-Lirma di tipo digitale con sistema di stampa a “getto d’inchiostro”, proprio come per le moderne stampanti dei calcolatori.
Il caratteristico punzone è uno dei pochi, in tutto l’universo delle “rosse” italiane, che riporta al suo interno l’indicazione del modello e della matricola dell’affrancatrice. Nel caso in questione, le prime due cifre (65) del numero indicano il modello (IJ 65) mentre le altre 6 cifre (121240) costituiscono il numero di matricola. Dalla matricola è possibile risalire all’anno di costruzione perchè le sue due prime cifre (12) indicano l’anno (10 = 2000, 11= 2001, 12= 2002, ecc.) mentre le rimanenti 4 cifre (1240) costituiscono una numerazione progressiva, unica per una serie di modelli, che ricomincia da zero ogni anno.
Questo punzone è stato ed è attualmente utilizzato solamente da affrancatrici LIRMA (successivamente Neopost-Lirma, ora Neopost).
L’uso di questo tipo di punzone iniziò nel 1999 (conosco una impronta del 6 luglio) con le affrancatrici digitali modello SM 26 della LIRMA prima con valuta in Lire e successivamente (dal 2001) con valuta in Euro, ma tutte con sistema di stampa a “trasferimento termico”.
I punzoni dei modelli SM 26 hanno una ulteriore caratteristica: nel riquadro contenente l’importo dell’affrancatura, compare anche la sigla dell’affrancatrice: L SM26 (dove la “L” significa LIRMA), per la versione in Lire, e € SM26, per quella in Euro. In questi casi, il numero, a 5 o 6 cifre, posto nel riquadro in basso indica solo la matricola (vedere i 2 allegati).
Per altri modelli a getto d’inchiostro la matricola può essere preceduta dalle cifre 35 o 45 per i modelli IJ35 e IJ45, rispettivamente; oppure da due lettere tra cui PI per i modelli in dotazione ad uffici e centri postali; per queste ultime affrancatrici la composizione della matricola segue altri criteri.
Cordiali saluti.
Milvio Bencini (socio AICAM)
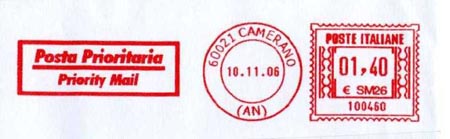

Ringrazio tanto Milvio Bencini per la completa ed esauriente risposta, in effetti io mi occupo prevalentemente di storia postale 1861-1961 perciò le mie rosse sono quelle classiche con il "punzone di stato". Mentre tutto è mutato, io ignoravo il cambiamento, il mondo delle rosse si è completamente trasformato ed attualmente si utilizzano altri sistemi e come mi svela il Bencini: "L’impronta è di una affrancatrice Neopost-Lirma di tipo digitale con sistema di stampa a “getto d’inchiostro”, proprio come per le moderne stampanti dei calcolatori."
Vittima della mia distrazione (e ignoranza) in effetti ero arrivato a ipotizzare, per quell'impronta con difetti di stampa, perfino una eventuale frode postale.
Negli ultimi anni la posta del nostro paese ha attraversato, e sta ancora attraversando, tali e profonde trasformazioni che forse nemmeno gli storico-postali più attenti riescono a seguirne tutte le novità, per questo è necessario specializzarsi. A mia scusante devo rilevare che forse è una mancanza simmetrica fra i cultori dei diversi periodi, penso di non essere il solo ma in buona compagnia di altri collezionisti attenti solo al loro orticello.
Per fortuna c'è "il postalista" che permette gli interventi a più voci, questo apre orizzonti sconosciuti ai distratti, ci fa diventare una comunità dialogante che aiuta a superare le angustie della specializzazione. Perciò diciamolo FORTE: se Monticini non ci fosse bisognerebbe "INVENTARLO". Grazie Roberto!
M. Bignami
|
allego le scansioni di due lettere molto antiche, rispettivamente del 1483 e del 1525, entrambe recanti nitido sigillo a secco raffigurante il leone di S. Marco. Vorrei inserirle nella mia collezione di storia postale ma purtroppo non riesco a capire nulla o quasi del loro contenuto. Nella prima si legge: ''Magnifico ... Frater hon: Significo a Vostra ... hoggi haver dato a Jacomin da Milan, capo de schiopetieri (?), portador de questa, ducati XXI. La vostra ... adunque sera cauta a no li dara piu danari per el ...: nit plura / bene valit (?): ex castris Venicia (?) apud castrum Mantua (?). die 20 novembr 1483. Antonius ... Provisor ex erat''. Nella seconda nebbia totale a parte la destinazione, che non è certamente Tripoli come riportato nella descrizione dell’asta a cui l’ho acquistata, ma credo sia Brescia (Brixie). Mi sembra di aver capito che nel testo si accenni agli spostamenti delle truppe spagnole nel Nord Italia, essendo quelli gli anni in cui si combattè la guerra tra Carlo V e Francesco I di Valois (alleato di Venezia) per il predominio dell’Italia e dell’Europa. La data (24 jenaio 1525?) dovrebbe essere di poco precedente la battaglia di Pavia (24/02/1525), durante la quale gli imperiali di Carlo V sconfissero i francesi e catturarono Francesco I.
Chiedo quindi a Roberto se gentilmente può chiedere ai suoi lettori ed esperti di darmi una mano a decifrare i testi.
Alessandro Chiarelli




|
salve, navigando oggi in internet e alla ricerca di siti di filatelia, ho scoperto il vostro, cosi ho pensato di chiedervi un'opinione su alcuni,di una discreta collezione di francobolli che ho. Sono curiosa di sapere se hanno un valore o no, e, poichè ho francobolli di tutto il mondo, anche abbastanza datati, mi piacerebbe documentarmi, ma non so come fare! mi farebbe piacere un consiglio.grazie
luisa

 
risponde Franco Moscadelli:
Gentilissimoa sig.na Luisa, ho visto i francobolli postati nell'e-mail: il 20 cent. di Libia, complementare della serie pittorica con la Sibilla Libica e quello di Fiume con l'emissione del 1920 con l'effigie di D'Annunzio. Le devo subito dire che hanno scarso valore, pochi centesimi di euro, poichè comunissimi e in mediocre stato di conservazione. Comunque se ha molti francobolli da controllare, può procurarsi un catalogo italiano di Regno con le Occupazioni e le Colonie ( Sassone-Enciclopedico- Unificato, anche usati di due o tre anni fa vanno bene) cosicchè può farlo da sola. In quanto ai francobolli mondiali il catalogo suggerito l'Yvert & Tellier oppure lo Scott. Buona ricerca e vive cordialità.
|
chiedo informazioni sulle tariffe postali,
per lettere non affrancate nei primi anni del Regno d'Italia.
Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.
Capellini Gino

risponde Marino Bignami:
la lettera parla chiaro (anche se non è molto chiara).
Scusa il giro di parole ma sul fronte è segnato un 2 che è scritto male e si vede poco. All'epoca significava 2/10 di Lira cioè 20 cent. da pagare dal destinatario alla consegna. Data la piccola località (Acqualunga ) è stata eseguita probabilmente da un "portalettere rurale" che l'aveva già pagata all'ufficio postale di riferimento e doveva poi farsi rimborsare dal destinatario; da tenere presente che nei due anni iniziali dell'Unità (1861 - 1863) la tariffa era la stessa sia che a pagare fosse il mittente o il destinatario (esclusa la Toscana ed il napoletano). Successivamente per incentivare l'uso dell'affrancatura preventiva (con i francobolli) la tariffa era stata diversificata.
Ciao Bignami
|
"Un lettore del mio sito < www.postaesocieta.it > mi ha inviato la seguente immagine e mi ha fatto una domanda a cui non so rispondere. Il lettore chiede: il mittente era un lavoratore coatto residente o un deportato?
Analizzando l'immagine ho rilevato che è affrancata, questo presuppone possesso di denaro, quindi non deportato. Ho notato che sulla busta c'e impresso un timbro che corrisponde all'indirizzo vergato dal mittente e la parola (WERKHEIM). Non conosco il tedesco e una scorsa al dizionario mi ha fatto pensare a "casa del lavoro", "ricovero", "ostello per il lavoro", questo mi fa supporre che il mittente fosse un prestatore d'opera andato in Germania di sua volontà a lavorare e alloggiasse in una struttura organizzata dalla fabbrica. La busta reca tracce della censura tedesca effettuata a Monaco di Baviera.
Si potrebbe anche arguire che il timbro applicato sul fronte, e uguale all'indirizzo, fosse applicato dall'ostello e magari obbligatorio per i lavoratori esteri colà trasferiti, per essere facilmente identificabili.
Chi mi può dare informazioni su questo dilemma?
Grazie
Marino Bignami

|
è possibile avere delucidazioni in merito a questo bollo?
ho fatto
ricerca sul Gallenga e non ho trovato nulla, sul Ravasini, viene sì riportato a pag. 178 ma con colore rosso e nelle misure 50/14 mm.
mentre quello in mio possesso è di 48/14 mm. e di colore nero.
Ringraziando anticipatamente porgo distinti saluti
Luigi DE FELICE

Risponde Thomas Mathà:
suggerimento: quando si fanno domande, è di grande aiuto indicare
luogo e data di provenienza (se noti)!
è il bollo sanitario di Trieste, catalogo De Zanche n. 8.4.3,
pag. 123 cordiali saluti
Precisazione di Attilio Piantoni:
Ho appena letto la risposta di
Thomas Mathà su bollo di disinfezione di Trieste numero 8.4.3.
sull'edizione in mio possesso
del 2008 è a pagina 110.
|
GIUSEPPE PALLINI, VOLENDO PREPARARE UN ARTICOLO SUGLI UFFICI POSTALI CHE USARONO LE DICITURE MANOSCRITTE "INSUFFICIENTE" O SIMILI, DA PUBBLICARE SUL "MONITORE DELLA TOSCANA", CHIEDE AI LETTORI DI "IL POSTALISTA" DI SEGNALARE, SU QUESTO SITO O A LUI DIRETTAMENTE (beppepallini@clicsi.net) I CASI A LORO NOTI. MEGLIO SE ACCOMPAGNATI DA UNA FOTOCOPIA.
|
salve volevo un parere grazie!!!
Vincenzo
Alla domanda di informazioni sul tre lire di Toscana postato non possiamo che rispondere che si tratta probabilmente di una falsificazione del tre lire del governo di Toscana su carta con imitazione della filigrana del 1857, con il colore giallo ocra chiaro abbastanza ben imitato. Naturalmente con la visione diretta e non da una scannerizzazione si classificherebbe meglio il falso. Potrebbe trattarsi di una delle ristampe fatte a suo tempo dal Fournier o dallo Sperati. Comunque a mio parere si tratta di un falso per i suoi errori di stampa che riporta, per il tassello non conforme e per ...i grandiosi margini.....se fosse vero sarebbe il più bel 3 lire al mondo. Cari saluti,
F.Moscadelli
|
Posseggo un foglio di 100 esemplari gommato del 25 centesimi verde raffigurante Vittorio Emanuele III con sovrastampa G.N.R. in rosso. E' possibile per cortesia sapere una quotazione approssimativa?
Grazie Lorenzo Monguzzi
risponde Franco Moscadelli
Egregio sig . Monguzzi, per il foglio da 100 esemplari da 25 cents. verde soprastampato GNR di cui mi chiede un parere, sarebbe auspicabile anche una perizia per controllare se la soprastampa sia di Verona oppure di Brescia.
Come stima approssimativa si potrebbe dare al primo un valore venale da 100/120 ?, per la seconda ipotesi si potrebbero passare i 1000 ? in stato di ottima conservazione e buona gommatura, naturalmente originali. Mi auguro per lei che il foglio in suo possesso sia "bresciano"!
Vivi saluti,
|
|
Mi è capitato di vedere ultimamente questa cartolina postale da cent. 7 1/2 con affrancatura supplementare di cent. 4. Mai sentito parlare di una tariffa di cent. 11 1/2. Credo che il mittente, avendo disponibile una sola parte dell'intero postale, lo abbia voluto portare alla tariffa di un normale intero, cioè cent. 10, e abbia usato due francobolli da cent. 2, eccedendo di un centesimo e mezzo per non far tassare la cartolina. Se sbaglio, vorrei che qualcuno mi desse la spiegazione giusta. L'annullo è GROSSETO 10 11 98, il bollo d'arrivo SIENA 11 11 98.
Giuseppe Pallini

risponde Carlo Sopracordevole (5)
Prendo atto della comunicazione di Bignami al quale desidero soltanto suggerire, a livello amichevole, di ripensarci due volte prima di scrivere anche perché, come è noto, “scripta manent”. E’ comunque un fatto che il trattamento delle CP RP 7 ½ + 7 ½ causò di frequente ambiguità di interpretazione di fronte a qualche uso anomalo sia per l’interno sia per l’estero, risolto solo in parte con l’emissione dei tipi da 5 +10. Quanto al fatto che il pezzo presentato da Pallini non sia stato tassato, non posso che rispondere che esistono moltissimi casi di mancata tassazione, per vari motivi: fretta, distrazione, incuria, pigrizia, errore, ecc. L’uso postale non è di certo una scienza esatta.
risponde Marino Bignami (4)
Mi sono riletto tutto attentamente e devo ammettere che Sopracordevole ha ragione. Da quanto riportato a pag.94 e seguenti dell'opera citata, è descritto e messo in evidenza in corsivo che l'amministrazione accettava la tariffa ridotta della domanda solo se fosse stata allegata alla risposta, e in caso di mancata integrazione "saranno assoggettate ad una soprattassa di 5 centesimi". Da ciò ho arguito che l'integrazione da applicare fosse la metà, perchè in linguaggio postale "soprattassa" è sempre stato il doppio del mancante, ma evidentemente mi sono sbagliato. Sull'opera citata è riportata perciò una stranezza evidente (e da sottolineare), quando ricorda che la "soprattassa" (da applicarsi con segnatasse a destino), in caso di invio non integrato avrebbe dovuto essere uguale all'integrazione di affrancatura.
Ho citato il regolamento posteriore del 1908 perchè, non avendone altri precedenti, pensavo esistesse una qualche omogeneità di comportamento dell'amministrazione postale. Nel mio intervento precedente ho usato una forma dubitativa, perchè logicamente solo i regolamenti danno certezze nelle procedure postali. Il chiarimento on- line è senz'altro servito a puntualizzare dei dubbi; evidentemente le cartoline con risposta del 1898 sono nate con un regolamento pasticciato e a distanza di tanti anni creano ancora confusione. Leggo perciò la replica di Sopracordevole come un chiarimento su quanto lui stesso ha scritto su “Umberto, una serie coi baffi”. Altra domanda: la cartolina di Pallini, se era sottoaffrancata, perchè non è stata tassata?
risponde Carlo Sopracordevole (3)
Mi sono accorto solo adesso del pur cortese intervento di Marino Bignami in merito alla mia risposta al quesito di Giuseppe Pallini sulla cartolina da 7 e ½ c. ma mi trovo un po’ a disagio a replicare alle obiezioni che vengono mosse. Infatti, come si fa a fare riferimenti a un regolamento postale del 1908 quando noi stiamo parlando di una cartolina del 1898, di 10 anni prima, nel momento in cui la struttura stessa della CR RP era ben differente nei suoi valori facciali, passati da c. 7 ½ + 7 ½ a c. 5 + 10 ed era in vigore un altro regolamento?
In un commento esplicativo non ci si può appoggiare a riferimenti non appropriati!
Ma senza andare a esaminare sempre i regolamenti (cosa comunque opportuna e lodevole e possibilmente supportata dalla verifica sul materiale, allora bisogna prendere quelli adeguati e non quelli successivi!), basterebbe esaminare il materiale in circolazione negli anni ’90 e constatare come si ritrovino molti casi di esemplari della parte Domanda integrati con 5 centesimi, mentre le Risposte non portano mai integrazioni (a parte rari usi per raccomandazione o espresso altri casi assai saltuari), perché la regolare integrazione a 20 di due parti staccate si attuava proprio con l’applicazione dei 5 c. sulla Domanda: tutte cose chiarite nei capitoli del libro di Bruno Crevato Selvaggi su “Umberto, una serie coi baffi”, di Umberto, citato da Bignami solo per la pag.48 ma poi molto più esauriente alle pagine da 94 a 98, sia nei casi di spedizioni interne sia estere delle cartoline postali con risposta pagata da 7 ½ + 7 ½ . Non starò qui a riprendere tutto il testo perché chi ne fosse interessato può benissimo andarlo a consultare direttamente.
Non posso che ribadire allora la mia primitiva risposta senza modifiche e ripensamenti: mancava 1 centesimo per i motivi che ho esposto. No, signor Bignami, Pallini NON aveva ragione.
Desidero invece cogliere l’occasione dell’ospitalità del Postalista per precisare che i testi richiamati da Bignami sul citato libro di Umberto, a proposito della parte sugli interi (e quindi anche alle CR RP) sono stati tutti scritti da me, come confermerebbe subito Crevato stesso. Anche le illustrazioni di interi riproducono esemplari che facevano (e fanno) parte della mia collezione. Se poi il mio nome sul libro è saltato, ciò fu dovuto malintesi al momento di andare in stampa, cosa che non mi ha certo rallegrato. Se si legge la presentazione di Franco Filanci, questa mia affermazione risulta abbastanza chiara.
risponde Marino Bignami (2)
Mi spiace contraddire un cosi
autorevole personaggio (specializzatissimo in interi) ma non sono
d'accordo. Ha ragione Giuseppe Pallini quando suppone
l'integrazione alla tariffa intiera, perchè la riduzione di
tariffa concessa dall'amministrazione postale serviva a promuovere
l'uso delle cartoline postali e a gratificare il mittente che
sborsava l'importo totale delle due cartoline. Infatti per
l'amministrazione la cartolina era molto vantaggiosa rispetto alla
lettera, era più leggera, evitava i controlli del peso, con grande
risparmio di ingombro e tempo, ed in caso di separazione con
l'integrazione dell'affrancatura della prima parte (Domanda) le
poste non perdevano nulla perchè la prima parte sarebbe stata
integrata e la seconda in ogni caso avrebbe comunque viaggiato a
tariffa ridotta; era un rischio calcolato e previsto per la sola
corrispondenza interna.
Bruno Crevato Selvaggi nella pubblicazione "Umberto una serie coi
baffi" edito da Poste Italiane a pag. 48 riporta: "..era sempre di
15 cent., ma ora la domanda poteva ufficialmente viaggiare
separata dalla risposta purchè fosse integrata da francobolli
oppure tassata per il mancante..." alla stessa maniera Franco
Filanci su "Floreale & C. la serie che non c'è" anch'esso delle
Poste italiane mostra l'esempio di una cartolina con risposta per
l'interno spedita all'estero integrata nella risposta con
francobolli e nella didascalia precisa "...aggiungere 6 contesimi
di francobolli, da applicarsi in egual misura sulle due parti
delle cartoline, cioè per 3 centesimi sulla proposta e 3 centesimi
sulla risposta. (Bollettino postale n°20, 1903, § 308)."
La medesima procedura venne poi richiesta quando furono emesse le
cartoline cent. 5 + 10 (vedi sotto Art.97 1908).
Non penso che le Poste richiedessero un trattamento diverso per
l'interno tenendo presente, come gia accennato, che per norme
U.P.U. la riduzione non era valida per l'estero.
Ho il regolamento postale del 1908 uscito subito dopo il cambio di
affrancatura delle cartoline doppie che ricorda Sopracordevole, il
pasticcio dello stesso valore ridotto di affrancatura sulle due
parti, fu risolto facendo obbligatoriamente viaggiare le due parti
(cent.5 + 10) insieme all'andata, e se separate, con la prima
parte integrata con altri 5 cent. (vedi sotto il regolamento sopra
menzionato). Inoltre lo stesso regolamento prevedeva anche il caso
di errore da parte del mittente nello scrivere la missiva sulla
risposta invece che sulla domanda; in tal caso le poste
accettavano la risposta scritta sulla prima parte da 5 cent.
purchè viaggiassero le due parti unite, quindi con uno scambio di
cartolina. Questa attenzione da parte delle poste mi fa ritenere
che non richiedessero una incongruenza come una affrancatura
superiore al porto in caso di separazione delle due parti.
A completamento di quanto sopra espresso allego testo del
regolamento postale del 1908 Art.97
" Art. 97 - Le cartoline con risposta, indirizzate nell'interno
del Regno od all' estero, debbono essere impostate con la seconda
parte in bianco: tutt'al più con 1'indirizzo predispostovi,
giammai riempiute in ambedue le parti, o con la seconda cucita od
incollata con la prima, in modo che lo scritto rimanga chiuso o
coperto.
Nel servizio interno la parte riservata alla risposta può essere
adoperata separatamente, per corrispondere con qualsiasi persona.
Il mittente della risposta può lasciarvi attaccata la prima parte
già riempiuta ed adoperata. Può anche adoperare per la risposta la
prima parte della cartolina, quando la missiva sia stata fatta,
per errore, riempiendo la risposta; ma in questo caso deve
lasciare unite le due parti.
Le prime parti di cartolina con risposta che sieno spedite senza
la seconda, non sono assoggettate a tassa se debbano distribuirsi
nel distretto dell' ufficio d' impostazione. Quelle a destinazione
di località non compresa nel distretto sono tassate cent. 10,
quando non sia stato aggiunto sulla cartolina un francobollo di
cent. 5.
La francatura delle cartoline interne con risposta, dirette
all'estero, deve essere completata applicando un francobollo da
cent. 5 sulla missiva; in caso diverso sono passibili della tassa
di cent. 10.
Le singole parti di cartoline doppie da cent. 20 possono essere
spedite separatamente nell' interno del Regno, ma non all'
estero."
Marino Bignami
risponde Carlo Sopracordevole (1)
Le cartoline postali con risposta pagata con tariffa interna da c. 7 ½ + 7 ½, in uso fino al 1906, ebbero una normativa abbastanza complessa derivata proprio da quella particolare tariffa agevolata di 15 c. totali che poteva provocare qualche complicazione e interpretazione, risolta poi in parte con l'emissione di tipi da c 5 + 10 nel 1906. Nel cercar di comprendere l'esemplare riprodotto, bisogna tener conto di una cosa: la seconda parte "Risposta" poteva viaggiare regolarmente da sola a c. 7 ½ mentre la prima parte, impropriamente detta "Domanda", per costare solo 7 ½ doveva viaggiare unita alla Risposta. Era però consentito spedire le due parti distaccate ma, in questo caso, esse diventavano due cartoline "semplici", la cui tariffa era di 10 c. l'una e non fruivano più dell'agevolazione complessiva di 5 c. Dovevano quindi scontare 10 centesimi l'una, 20 in totale. Quindi, premesso che la Risposta andava sempre bene a 7 ½, senza necessità di integrazione alcuna,ecco che la Domanda spedita da sola doveva invece essere integrata con 5 centesimi così che 12 ½ più 7 ½ diventassero 20. Mi sembra il caso della cartolina in questione che, per conto mio, viaggiò da sola carente di 1 centesimo e non in eccesso di 1 e mezzo.
|
|
Sono uno studente di scienze politiche laureando con tesi in
storia dell'america del nord con una particolare attenzione alla
storia degli stati uniti d'america.
Un argomento attento quindi è la storia del racapito negli stati
uniti con riferimento al nostro.
Ho saputo che il recapito italiano è stato riorganizzato su base del
sistema degli U.S.A. o del Canada,ma purtroppo no riesco a trovare
nulla sulla rete e comunque su supporto cartaceo.
Vi prego postalisti aiutatemi, ci terrei molto ad affrontare la tesi
sull'argomento postale.
Luigi Pellegrini
Risponde Luigi Impallomeni
Scrive Pellegrini :
Ho saputo che il recapito italiano è stato riorganizzato su base del
sistema degli U.S.A. o del Canada,ma purtroppo non riesco a trovare
nulla sulla rete e comunque su supporto cartaceo.
Sarà forse l' opposto ?
Dal 1792 negli Stati Uniti, in seguito alla proclamazione
d'Indipendenza, si verificò un rapido sviluppo del servizio postale,
la cui libertà era tutelata da norme severe: gli uffici postali
erano 76 e 3 mila erano i chilometri di percorso coperti da corrieri
privati.
Intorno al 1800, negli Stati Uniti e in Inghilterra il servizio
telegrafico venne destinato anche ad usi commerciali. Da una parte
all'altra dell'oceano si accese un ampio dibattito su chi, tra Stato
e settore privato, dovesse controllare la circolazione delle
informazioni e sostenere le spese per l'installazione e il
funzionamento delle reti di comunicazione. È proprio a seguito di
queste riflessioni che nel corso del secolo sarebbe poi nato il
concetto di "servizio pubblico".
Nel 1847, il francobollo venne adottato in Usa, l'anno successivo in
Francia.
Gli Stati italiani introdussero il sistema con francobolli propri a
partire dal 1850.
Un esempio di servizio postale veloce ed eroico, entrato addirittura
nel mito delle grandi epopee hollywoodiane, fu il Pony Express,
introdotto negli USA nel 1860 e utilizzato con grande successo per
soli 19 mesi, quando venne rimpiazzato dalle linee telegrafiche.
Straordinaria era l'efficienza dei 157 servizi di rifornimento e
cambio dei cavalli posti lungo il lunghissimo
tracciato: oltre 3 mila chilometri di strada dal Missouri alla
California, attraverso Kansas, Nebraska, Colorado, Wyoming, Utah e
Nevada. E divenne un mito l'abilità degli 80 giovanissimi corrieri,
che guadagnavano fino a 125 dollari al mese, macinando anche 120
chilometri al giorno. Oltre a loro, il servizio impiegava 400
persone. Prima dell'istituzione del Pony Express, il servizio
postale impiegava non meno di un mese per raggiungere gli emigrati
della California da New York (dove arrivava la posta proveniente
dall'Europa).
|
Gentile Postalista, sono venuto in possesso di una cartolina di cui
non riesco a trovare tracce storiche o similari, potrebbe darmi dei
cenni e se la stessa ha un particolare valore commerciale dato la
singolarita'?
Nel ringraziarla anticipatamente
Cordiali saluti
 |
 |
|
Risponde Riccardo Bodo
Si tratta di una cartolina militare in franchigia con
stemma monocromo, appartenente ad un gruppo di emissioni di
propaganda stampate nel 1917. E' registrata sul catalogo
''Interitalia 2008'' con il n. 12D.8 e fa parte di una serie di
12 cartoline con proclami indirizzati ai soldati della 5.a
Armata. Il valore - per la CP usata - e' indicato in 50 euro. Le
cartoline della serie presentavano sul dritto, al di sotto dello
stemma che fa funzione di valore di affrancatura,
un'intestazione ''5.a Armata'' stampata in forma arcuata,
intestazione che sull'esemplare mostrato appare cancellata con
inchiostro da censura; anche sul verso risulta abraso il
riferimento alla quinta armata (la dicitura completa era
''Soldati della 5.a Armata''). In alcune cartoline il
riferimento all'armata era stato soprastampato con l'indicazione
della ''9.a Armata, ma in questo caso non escluderei un
intervento della censura militare.
Marino Bignami risponde A CARTOLINA DI PROPAGANDA "15 - "18
Egregio Signore,
La cartolina in questione è una delle innumerevoli cartoline propagandistiche della prima guerra mondiale.Il nuovo Pertile edizione del 1995 a pag.24 descrive, cataloga e mostra una miniatura in B/N fronte e retro della sua cartolina; venne emessa dalla 5^ Armata nel luglio del 1918 (probabilmente progettata prima di Caporetto). Per quanto riguarda il valore venale il Pertile la quotava in lire per un equivalente di 25 €.
Da parte mia posso aggiungere che mi ha maggiormente interessato la sfregiatura applicata dalla censura sia sul fronte che sul formulario. Come può vedere dalle illustrazioni allegate la frase 5^ ARMATA sulla parte propagandistica e la scritta sotto lo stemma dalla parte indirizzo sono state cancellate rispettivamente con abrazione della carta e con inchiostro di china, infatti dopo la disfatta di Caporetto la normativa sull'invio della corrispondenza era stata cambiata, vennero rifatti i bolli postali militari e vennero vietate scritte che potessero fare riferimento alle dislocazioni militari. Spero di essere stato esaustivo, saluti.


|
|
|
Ricevo il catalogo dell’asta Bolaffi Ambassador del 16-17 maggio 2008 e mi hanno molto stupito le immagini alla pagina 174 dove sono mostrati 3 blocchi del francobollo Gronchi Rosa (non)emesso nel 1961.
Infatti mi ha incuriosito il fatto che questi tre blocchi si presentano completamente diversi fra loro: il 2344 presenta nel margine di sinistra le onde sinusoidali meno distanziate dal francobollo rispetto a quelle presenti nei lotti 2341 e 2342.
Inoltre i tre blocchi
hanno una particolarità veramente strana: il 2342 ha un foro d’invito (o foro-pilota) della dentellatura a blocco rivolto verso l’alto, il
2344 il foro d’invito rivolto a destra mentre il 2340 non ha nessun foro d’invito.
Questo stato di cose mi fa pensare che vi possa essere stata almeno due composizioni di stampa per via delle onde sinusoidali diverse mentre per l’operazione di dentellatura a blocco vi siano stati almeno tre impianti distinti. Oppure… oppure cosa?
Chi mi sa chiarire
questo dubbio?
Danilo Paolo Vignati
risponde Riccardo Bodo
Ho letto la domanda di Danilo Vignati sui blocchi del Gronchi rosa in asta Bolaffi: credo che occorra considerare che questi francobolli in rotocalco e dentellati a blocco erano stampati in composizioni di quattro quarti, poi ritagliate in fogli di 40 esemplari.I quarti hanno in genere i fori pilota sui bordi esterni della composizione mentre non lo presentano sui lati che guardano verso l'interno della composizione. Quindi il primo quartino della composizione ha il foro pilota in alto e a sinistra e non lo ha sul lato destro e su quello inferiore; il quartino che lo affianca ha viceversa il foro pilota in alto e a destra e cosi' via per i quarti inferiori. Anche le sinusoidi hanno differenti distanze a seconda se sono sui lati esterni della composizione o cadono negli interspazi interni della composizione. Questo, almeno, e' quanto rilevo guardando alcuni fogli ancora uniti a coppie di altre emissioni dentellate a blocco di cui dispongo.
risponde Maurizio Vaudano
Il “Gronchi rosa” fu’ realizzato in rotocalco con la macchina da stampa Goebel a 2 colori. Tale macchina stampava utilizzando cilindri a
4 gruppi di impronte e la dentellatura (blocco) veniva effettuata sulla bobina dopo la stampa e prima del taglio in formati. Nello specifico ad ogni passata usciva una “tavola” composta da 4 fogli di 40 francobolli dentellati, per un totale di 160 “Gronchi”. I 4 fogli erano separati da un interspazio orizzontale e verticale.
Caratteristiche
della dentellatura.
Il perforatore a blocco ad ogni battuta perfora contemporaneamente tutti i lati di tutti i 160 francobolli presenti nella tavola. Sul bordo della tavola sui 4 lati compare il foro pilota, ossia un foro in piu’ di quelli che servono a contornare il francobollo. I fori pilota sono presenti solo sui lati esterni del blocco perforatore. Non sono quindi presenti nell’interspazio di separazione dei 4 fogli.
Caratteristiche delle sinusoidi.
Le onde
sinusoidali sono presenti nella zona dell’interspazio e anche lungo i bordi esterni della tavola.
Nell’interspazio verticale sono presenti 2 onde sinusoidali separate da una linea. La linea era il riferimento per il taglio della tavola e la separazione dei 4 fogli. Nei bordi verticali e’ presente invece 1 sola sinusoide vicino al francobollo affiancata da una linea. Nei bordi la distanza tra sinusoide e francobollo e’ inferiore rispetto a quella presente nell’interspazio.
Nell’interspazio orizzontale compare 1 sola sinusoide posizionata in prossimita’ di quello che sara’ il bordo inferiore del foglio dopo il taglio. La scritta “IL FOGLIO DI QUARANTA FRANCOBOLLI VALE L. 8200” e’
invece posizionata in prossimita’ di quello che sara’ il bordo superiore del foglio. I bordi orizzontali della tavola riportano una sinusoide e la scritta in accordo a quello gia’ descrtitto per l’
interspazio.
La dentellatura e le sinusoidi fanno si che all’interno della tavola si vengono a creare 4 fogli con caratteristiche diverse:
FOGLIO 1 – posizione in alto a sinistra della tavola.
Fori pilota
presenti solo sul lato sinistro e superiore.
Bordo sinistro con
sinusoide vicina e linea.
Bordo destro con sinusoide lontana.
FOGLIO
2 – posizione in alto a destra della tavola.
Fori pilota presenti solo
sul lato destro e superiore.
Bordo sinistro con sinusoide lontana.
Bordo destro con sinusoide vicina e linea.
FOGLIO 3 – posizione in
basso a sinistra della tavola.
Fori pilota presenti solo sul lato
sinistro e inferiore.
Bordo sinistro con sinusoide vicina e linea.
Bordo destro con sinusoide lontana.
FOGLIO 4 – posizione in basso a
destra della tavola.
Fori pilota presenti solo sul lato destro e inferiore.
Bordo sinistro con sinusoide lontana.
Bordo destro con sinusoide vicina e linea.
|
|